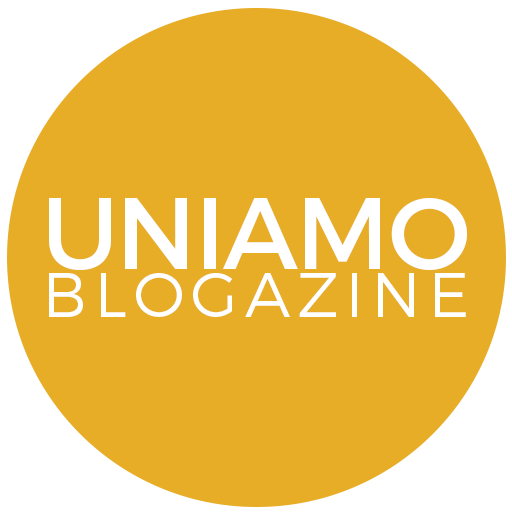Il confine tra cultura umanistica e tecnologie digitali è, oggi, uno spazio aperto e ibrido che genera competenze nuove. Il corso di laurea magistrale in Lettere Moderne si muove proprio in questa zona di intersezione, mentre connette il rigore dell’analisi testuale con gli strumenti smart delle piattaforme, la tradizione letteraria con le potenzialità dell’intelligenza artificiale, la capacità critica con il codice. La direzione didattica è chiara: formare figure professionali richieste in contesti in cui gli studi filologico-letterari incontrano l’innovazione, a cominciare dagli archivi in rete, dall’editoria avanzata, dai sistemi informativi per i beni culturali. Per capire come e perché questi nuovi profili stiano diventando centrali nell’ambito delle digital humanities applicate, abbiamo intervistato Giovanna Frosini, Presidente dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, e Sara Cambrini, Direttrice dell’Archivio di Stato di Pesaro Urbino.

Giovanna Frosini
Professoressa Frosini, nelle aule di Uniurb si formano giovani che studiano filologia e progettano banche dati e archivi digitali. Profili nuovi con competenze necessarie anche per l’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio?
Il nuovo corso magistrale che l’Università di Urbino ha attivato coglie un punto essenziale dei nostri studi: la solidarietà profonda fra tradizione e innovazione. Il nesso fra filologia e storia della lingua da un lato, e digital humanities dall’altro sta qui: senza una solida base di studi filologici e linguistici non si può costruire il futuro, e al tempo stesso la padronanza delle risorse informatiche approfondisce e rilancia le conoscenze. In questo punto di intesa si colloca uno dei progetti strategici dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, il Vocabolario della lingua di Boccaccio on line, che inizia dal Decameron, ma già propone di estendersi a tutte le opere volgari di Boccaccio.
Il VocaBO è una realizzazione innovativa, che tiene insieme per la prima volta l’annotazione linguistica al testo, un vocabolario digitale e le reti di relazione delle parole a seconda dei campi di significato. Permetterà così a studenti e studiosi di esplorare l’universo della lingua di Boccaccio in molteplici direzioni, diciamo in verticale e in orizzontale. Sono certa che il Laboratorio di Lessicografia digitale che sarà attivato interesserà molto gli studenti del corso magistrale, che potranno prepararsi a collaborare al nostro VocaBO, che è una grande impresa di squadra, in cui il lavoro intellettuale cooperativo è essenziale: perché si studia, si scopre, si capisce non da soli, ma insieme agli altri.
Uno degli obiettivi previsti dallo statuto dell’Ente è «favorire l’operosità dei giovani studiosi». Attraverso quali opportunità professionali?
È essenziale per l’Ente Boccaccio l’attenzione verso i giovani studiosi; vorrei dire che essa costituisce davvero uno degli obiettivi primari verso cui è orientata tutta la nostra attività. Favorire lo studio della figura, dell’opera, dei tempi, della fortuna di Giovanni Boccaccio per noi significa essenzialmente aprire a nuove vie di conoscenza, sperimentare nuovi percorsi e nuovi metodi di ricerca. E questo possono farlo, e sanno farlo, in primo luogo i giovani studiosi. A loro offriamo occasioni di formazione (come la Scuola estiva Un accessus a Boccaccio, che ogni anno dà la possibilità di intercettare le frontiere della ricerca), ma anche di confronto del proprio percorso di studio (il convegno internazionale Intorno a Boccaccio/Boccaccio e dintorni, rivolto a loro).
Offriamo, inoltre, opportunità di approfondimento e applicazione delle conoscenze, attraverso la collaborazione con i progetti che l’Ente ha attivato e persegue, che sono progetti con forte caratterizzazione sulle digital humanities: riguardano la ricostruzione della biblioteca di Boccaccio, il Decameron come opera e come sistema di conoscenze, e la lingua volgare di Boccaccio, a cominciare proprio dalla sua opera maggiore, quella che gli ha assicurato una rilevanza assoluta nella nostra storia letteraria, culturale e linguistica. E non escludiamo le applicazioni dell’intelligenza artificiale per meglio conoscere e interpretare l’universo del nostro autore.

Sara Cambrini
Dottoressa Cambrini, un’istituzione pubblica come l’Archivio di Stato di Pesaro Urbino ha bisogno di umanisti digitali?
Gli archivi storici hanno bisogno di personale con una solida preparazione scientifica e filologica, che la figura dell’umanista digitale possiede. Tali competenze “tradizionali” devono però essere unite ad una padronanza delle nuove tecnologie, indispensabile per chi si accosta oggi al mondo degli archivi. L’attitudine all’approccio storico e critico al testo e al documento, che si apprende tramite lo studio di discipline quali la filologia, la paleografia e la diplomatica, è solida base con la quale affrontare il documento archivistico, nella sua complessità di relazioni con il soggetto produttore, il soggetto conservatore, la stratificazione archivistica. Tuttavia, il mondo contemporaneo richiede la conoscenza delle tecnologie informatiche e multimediali alle quali l’archivistica si affida sempre di più, sia per la gestione, conservazione e fruizione dei documenti nativi digitali e degli strumenti di gestione dei flussi documentali, sia per lo sviluppo di progetti di fruizione e valorizzazione del patrimonio storico.
Oltre alle materie previste dal piano di studi della magistrale in Lettere Moderne, quali competenze occorrono per essere competitivi nei concorsi pubblici dei Beni culturali?
Molto importante nei concorsi pubblici – e nella professione – è la conoscenza del diritto amministrativo e del diritto dei beni culturali, la conoscenza di alcune discipline specialistiche legate all’Archivistica: penso all’Archivistica informatica. Non trascurabili sono le abilità informatiche, la padronanza e comprensione dei processi gestionali – penso all’iter complesso che porta alla nascita e allo sviluppo di un progetto di digitalizzazione – che si acquisiscono appieno entrando in contatto diretto con le istituzioni, ad esempio mediante quello strumento di formazione fondamentale rappresentato dai tirocini. Tuttavia, la formazione umanistica è – a mio parere – ancora oggi la solida base che permette di rispondere ai quesiti con maggiore proprietà e anche di affrontare lo studio delle materie specifiche che, comunque, vengono richieste nei singoli concorsi.