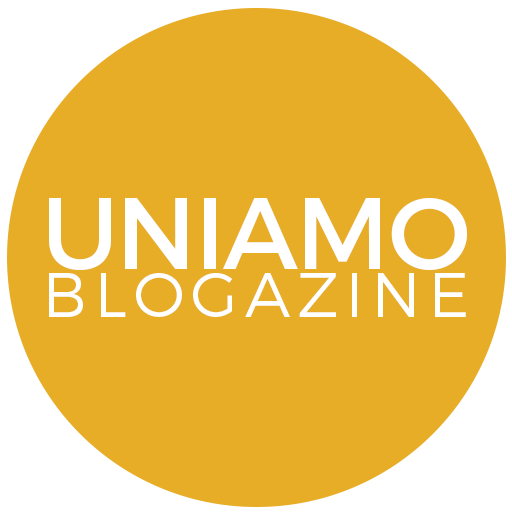La Professoressa Catia Grimani, docente di Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni, è entrata a far parte di recente del LISA Science Team selezionato dall’Agenzia Spaziale Europea. Di LISA abbiamo parlato in più di un post, eppure con orgoglio ci piace rilanciare l’informazione di tanto in tanto. Il Laser Interferometer Space Antenna è il primo osservatorio dedicato alla rivelazione delle onde gravitazionali direttamente dallo spazio, un colossale progetto di ricerca al quale Uniurb partecipa da molti anni. Nella rosa internazionale dei venti uomini e donne che orientano la missione scientifica, la Professoressa Grimani – unica presenza italiana – ricopre il ruolo di “complementary scientist”: una figura ibrida chiave che ha il compito di studiare gli effetti del meteo spaziale sugli strumenti a bordo dell’osservatorio, e di divulgarne l’impatto in comunità di ricerca interdisciplinari. Nell’intervista che segue, con la docente abbiamo parlato della sua passione per la scienza, e puntato i riflettori anche sulle altre missioni spaziali che coordina per Uniurb: LISA, LISA Pathfinder, Solar Orbiter e HASPIDE.
Professoressa Grimani, che significato ha per lei l’ingresso nel LISA Science Team?
Sono davvero contenta di far parte di questo importante team. Per me questa nomina ha un valore simbolico forte, io lo definisco l’Oscar alla carriera. Di fatto, è un riconoscimento alla determinazione con cui – sin dall’inizio – ho sostenuto l’importanza di studiare l’ambiente spaziale per il corretto funzionamento di una missione complessa come LISA.
Lo scorso novembre, ESA ha lanciato un bando aperto a ricercatori europei per ampliare l’ambito di indagine, includendo due aree complementari: space weather e multi-messenger.
Io sono stata selezionata per l’area dello space weather, la disciplina che descrive le variazioni dell’ambiente spaziale tra il Sole e la Terra; mentre il collega Zoltán Haiman dell’ISTA, l’Institute of Science and Technology Austria, si occuperà del fronte multi-messenger, che riguarda l’esplorazione dell’universo attraverso diversi “messaggeri”, quali onde gravitazionali, fotoni gamma e X, neutrini e altre particelle. Parliamo, quindi, di due settori non direttamente coinvolti nella rivelazione delle onde gravitazionali, tuttavia fondamentali per estenderne l’impatto scientifico.
Prima di esplorare la missione LISA, non posso non chiederle: cosa le fa brillare ancora gli occhi quando parla di ricerca scientifica?
Sono cresciuta nella frazione di un paese che conta 500 abitanti, in una famiglia senza laureati, eppure già da bambina avevo le idee chiare sul futuro. La scienza è sempre stata per me una necessità interiore. Per fare ricerca non serve solo l’intelligenza, serve forza. Il mio campo è la scienza di punta: quella in cui si immagina qualcosa che ancora non esiste, in cui si insiste anche quando nessuno ci crede. E se hai ragione, quella scoperta porta il tuo nome. Oggi posso dire di aver costruito tutto da zero, spesso controvento. Ogni scelta è stata ponderata, e alla fine, sì, sono diventata esattamente ciò che volevo essere.
Raccontiamo la missione spaziale LISA?
LISA è la prima missione spaziale progettata per rivelare onde gravitazionali direttamente dallo spazio. L’osservatorio si compone di tre veicoli spaziali, che verranno lanciati a bordo di un razzo. Una volta in orbita, i tre moduli – o satelliti – si disporranno in modo tale da formare un triangolo equilatero a una distanza di 2,5 milioni di chilometri l’uno dall’altro, pari a circa sei volte la distanza tra la Terra e la Luna. I satelliti si scambieranno segnali sotto forma di raggi laser che si propagheranno lungo i lati del triangolo. Ogni modulo ospiterà al suo interno due masse di test, ossia due cubi di oro e platino sospesi in caduta libera che fungono anche da specchi per i raggi laser.
Misurare eventuali variazioni infinitesimali nella distanza tra le masse, causate dal passaggio di un’onda gravitazionale, sarà l’obiettivo della missione. In questo modo, LISA rileverà variazioni dell’ordine di miliardesimi di millimetro su distanze di milioni di chilometri, per cui parliamo di risultati impossibili da ottenere sulla superficie terrestre. Direttamente nello spazio, si potranno, quindi, studiare fenomeni astrofisici finora inaccessibili come la fusione di buchi neri supermassicci o l’origine dell’universo.
Nel 2016 abbiamo descritto questa tecnologia raccontando la missione pilota, LISA Pathfinder, che ha testato la sostenibilità dell’esperimento LISA nello spazio.
Esatto. La premessa è che il concept di LISA risale agli anni ‘70. Prima di avviare un programma scientifico così complesso, l’ESA ne ha verificato la fattibilità attraverso una missione preliminare su scala ridotta: LISA Pathfinder. Un laboratorio spaziale, lanciato nello spazio il 3 dicembre 2015, che riproduceva l’architettura operativa del futuro osservatorio LISA. Dopodiché, valutato il successo dei test, nel 2025 è stata avviata la fase di sviluppo industriale e quindi di costruzione dell’osservatorio, che andrà in orbita nel 2035.
Qual è il suo ruolo nel LISA Science Team?
Il collega Zoltán Haiman ed io, le new entry del LISA Science Team, siamo complementary scientist. La figura è stata introdotta dall’Agenzia Spaziale Europea come strumento di terza missione, per trasferire e divulgare i progressivi esiti del progetto e rafforzare l’impatto della ricerca in comunità scientifiche non strettamente legate allo studio delle onde gravitazionali. Il mio ruolo in LISA è, quindi, duplice.
Principalmente contribuisco a valutare in che misura le condizioni dello spazio interplanetario influenzano le prestazioni della missione. Quando parliamo di space weather, infatti, ci riferiamo alla meteorologia spaziale, ossia ai fenomeni prodotti dalle interazioni tra il Sole e l’ambiente interplanetario: emissioni di massa coronale, getti di vento solare ad alta velocità, fluttuazioni del campo magnetico, e molto altro. Tutti questi fenomeni possono interferire con il funzionamento dei fasci laser che collegano i tre satelliti di LISA e, quindi, compromettere la rivelazione delle onde gravitazionali.
Per cui arriva l’alert e lei indaga e valuta l’interferenza?
Semplificando molto, sì. Il mio compito più tecnico è quello di analizzare la natura di un eventuale disturbo. In seconda battuta, l’incarico che ho accolto è anche quello di agire come “ambasciatrice” dello space weather in ambito scientifico, diffondendo i risultati ottenuti per far conoscere il lavoro di LISA e anche per valorizzare dati alternativi rispetto al tema delle onde gravitazionali. Dati sui raggi cosmici, sul campo magnetico interplanetario, o dati sulla ricostruzione del vento solare, estratti attraverso modelli di intelligenza artificiale – sviluppati a Urbino – con la possibilità di usare queste informazioni per finalità astrofisiche più ampie.
In Uniurb, grazie al lavoro di Federico Sabatini e Andrea Cesarini, abbiamo messo a punto modelli basati sul machine learning che, a partire da misure indirette (raggi cosmici e campi magnetici), permettono di stimare parametri non direttamente rilevati da LISA. In questo senso, il nostro contributo va oltre il supporto tecnico e punta ad allargare l’orizzonte scientifico della missione stessa.
In quali altre missioni spaziali è coinvolta Uniurb?
Come Università di Urbino, il mio gruppo di lavoro – fra cui Michele Fabi e Mattia Villani – ed io, siamo attualmente coinvolti in tre missioni dell’Agenzia Spaziale Europea: LISA Pathfinder, LISA e Solar Orbiter. Parallelamente collaboriamo con l’INFN, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, al progetto HASPIDE che ha vinto una call competitiva da circa un milione di euro. Nell’ambito di questo programma, che ha come obiettivo la costruzione di un rivelatore di particelle solari ad alta energia, sono responsabile del work package dedicato allo spazio. Testeremo lo strumento il prossimo novembre a Trento e, nell’occasione, racconteremo risultati importanti che segnano l’ingresso dell’Ateneo anche nella progettazione tecnologica per lo spazio.
Nel 2035, quando LISA sarà in orbita, dove si immagina e con quali pensieri?
Quando l’osservatorio LISA sarà lanciato io sarò in pensione. Seguirò tutto da lontano, probabilmente, ma ciò che davvero conta è che, con me o senza di me, lo space weather sia stato riconosciuto come parte integrante del team scientifico della missione. E che questo riconoscimento, dopo vent’anni di lavoro, sia destinato a restare, al di là delle persone.
Il mio auspicio è che l’Università di Urbino continui a far parte di questo percorso.
Quando LISA sarà operativo si aprirà una nuova fase di analisi e di pubblicazione dei dati raccolti. Parliamo di anni di lavoro e una mole di informazioni enorme, con un potenziale scientifico straordinario. Mi auguro quindi che dopo di me, a Urbino, qualcuno continuerà a mantenere viva la presenza dell’Ateneo in un progetto di ricerca che è un investimento nel futuro anche del territorio.