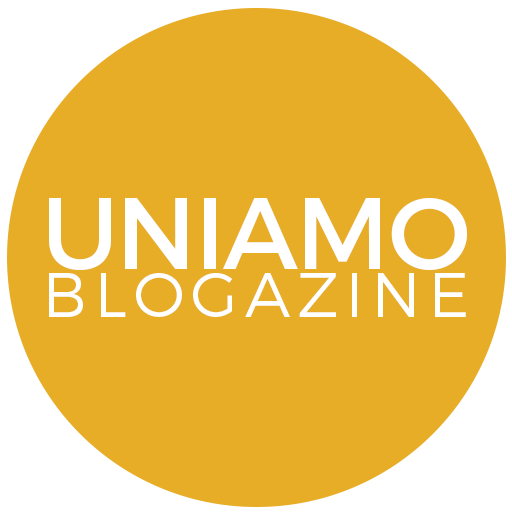SAVEMAR – Support to the Activities for the Valorization and Enhancement of MArine Resources rappresenta un interessante modello di innovazione interdisciplinare applicato al mare. Inquadrato nello Spoke 2 del National Biodiversity Future Center (NBFC): il primo Centro Nazionale di ricerca e innovazione dedicato alla biodiversità finanziato dal MUR, il progetto PNRR è stato coordinato dall’Università di Trieste e sviluppato in collaborazione con l’Università di Urbino e l’Università di Foggia. Lo studio ha integrato restauro, bioinformatica e biotecnologia con l’obiettivo di sperimentare tecnologie avanzate che rispondano in chiave sostenibile alle sfide “ambientali, economiche e sociali legate alla biodiversità marina”. Un finanziamento dedicato di 520.000,00 € – su un totale di 2.233.000,00 € – ha consentito a Uniurb di contribuire all’indagine attraverso attività operative di campionamento stagionale lungo l’Adriatico, che hanno raccolto dati sulla biodiversità e sullo stato di salute degli ecosistemi marini.
Ne parliamo con la Professoressa Antonella Penna, docente di Ecologia e Referente del progetto SAVEMAR per Uniurb.

La Professoressa Antonella Penna
Professoressa Penna, qual è l’obiettivo del progetto e in che modo SAVEMAR coniuga ricerca scientifica, sostenibilità ambientale ed economia circolare?
Il progetto SAVEMAR – Support to the Activities for the Valorization and Enhancement of MArine Resources – Spoke 2, finanziato dal Centro Nazionale per la Biodiversità NBFC fa parte del gruppo dei cosiddetti progetti a cascata. È un modello interdisciplinare di innovazione che integra restauro, informatica, ed ecologia. L’obiettivo è sviluppare e potenziare strumentazioni già esistenti e adottare tecnologie avanzate per affrontare in modo sostenibile i problemi ambientali, economici e sociali legati alla biodiversità marina. SAVEMAR si concentra sullo sviluppo di protocolli per il restauro della biodiversità e delle funzioni ecosistemiche, con l’implementazione di pipeline bioinformatiche per il metabarcoding – cioè l’analisi del DNA ambientale – applicate a tutti gli organismi marini, quindi a tutto il microbiota unicellulare o fitoplancton che costituisce la base della catena alimentare. In questo modo non si monitora solo la biodiversità, ma anche la funzionalità degli ecosistemi marini, in particolare nel Mar Mediterraneo.
SAVEMAR comprende altre attività?
Un’ulteriore parte del progetto riguarda lo sviluppo di processi di blue biorefinery, cioè l’estrazione di composti bioattivi di interesse farmaceutico, cosmeceutico e nutraceutico, attraverso cui promuove un modello di economia circolare basato sulla biodiversità marina. In generale, SAVEMAR contribuisce ad almeno quattro attività dello Spoke 2 dell’HUB Biodiversità: la strategia di restauro ecologico, la promozione di sistemi sostenibili per le risorse marine, lo sviluppo di tecnologie multi-omiche contro le minacce alla biodiversità e l’innovazione nelle biotecnologie marine.
Quale fase attraversa il progetto?
Il progetto è in fase di rendicontazione: la chiusura formale è stata a fine ottobre, ma le ultime attività operative si concluderanno entro dicembre 2025, in concomitanza con la chiusura dei fondi PNRR.
Su quali linee di ricerca si è concentrato il team di Uniurb?
L’Università di Urbino ha condotto la parte operativa in mare, realizzando campionamenti stagionali lungo un transetto marino che si estende fino a 15 miglia dalla costa di Pesaro, in corrispondenza della foce del fiume Foglia.
Che tipo di campionamenti ha eseguito?
Il nostro gruppo di studio di Urbino, nell’ambito del progetto PNRR SAVEMAR, è l’unica Unità di Ricerca ad aver compiuto campionamenti in mare stagionalmente. Abbiamo raccolto campioni d’acqua e di sedimento in tre stazioni – a 1,6, 7,5 e 15 miglia nautiche dalla costa – acquisendo dati chimico-fisici e biologici con sonde oceanografiche CTD. Si tratta di un’estensione spaziale significativa rispetto al monitoraggio costiero tradizionale del nostro laboratorio di Ecologia Marina, perché, pur avendo trent’anni di esperienza in questo ambito, non ci eravamo mai spinti fino a 15 miglia nel Mare Adriatico.
Quando saranno disponibili i risultati e quali impatti si prevedono sul territorio?
I risultati saranno pubblicati nel corso del prossimo anno, al termine dell’analisi dei campioni. Ci aspettiamo di ottenere dati inediti sulla qualità delle acque, analizzata sotto il profilo chimico-fisico, biologico e della biodiversità. Studieremo inoltre l’influenza dei fiumi e degli apporti idrici dal Po fino alle coste marchigiane per valutare se modificano la struttura della colonna d’acqua o se, al contrario, confermano il mantenimento di uno stato ancora conservativo del Mare Adriatico.
Il finanziamento PNRR si è concluso di recente. Sono previste azioni che garantiscano continuità al progetto oltre il termine previsto?
Per proseguire lo sviluppo delle pipeline bioinformatiche, delle banche dati e delle analisi genetiche sarà necessario reperire nuovi finanziamenti, in particolare per garantire il supporto al personale tecnico-scientifico e alle attività di campionamento. Collaborazioni sono già attive con l’Università di Padova nell’ambito dello Spoke 1, con Greenpeace e l’Università di Genova – Dipartimento DISTAV in due campagne di monitoraggio: Mare caldo e Aree marine protette. La campagna Mare caldo è finalizzata allo studio dell’incremento termico delle acque marine, sia superficiali, sia profonde, in relazione ai processi di cambiamento climatico. Il progetto Aree marine protette mira invece a promuovere l’istituzione di nuove zone di tutela per la conservazione della biodiversità marina.
In collaborazione con la Professoressa Monica Montefalcone, dell’Università di Genova, sono stati effettuati campionamenti di DNA ambientale nelle aree marine protette dell’Asinara, in Sardegna, e di Torre Guaceto, in Puglia, con l’obiettivo di analizzare la struttura delle comunità bentoniche e pelagiche, di monitorare la presenza di specie aliene e valutare l’evoluzione di taxa sensibili, quali coralli molli e fanerogame marine (Posidonia oceanica). Le attività in corso richiederanno ulteriori risorse economiche per garantirne la prosecuzione e l’ampliamento.
Chiuderei con un commento sul laboratorio Uniurb di Ecologia e Biologia Marina.
Il nostro laboratorio di Ecologia e Biologia Marina porta avanti da anni studi e ricerche a fini scientifici, anche nell’ambito del controllo della qualità delle acque. Monitoriamo mensilmente e pubblichiamo i dati sulla pagina dedicata Qualità delle acque del portale dell’Ateneo: un unicum in Italia tra le Università, insieme alle ARPA italiane che, però, non sono Enti di ricerca accademici. Questo riconosce a Urbino un ruolo attivo nel panorama nazionale e internazionale delle scienze ambientali marine, accanto ai settori più tradizionali dell’Ateneo urbinate. Inoltre, il progetto apre nuove opportunità per studenti e ricercatori: tesi, tirocini e contratti di ricerca in un settore di indagine in crescita, che vede la nostra Università presente ai tavoli scientifici nazionali.