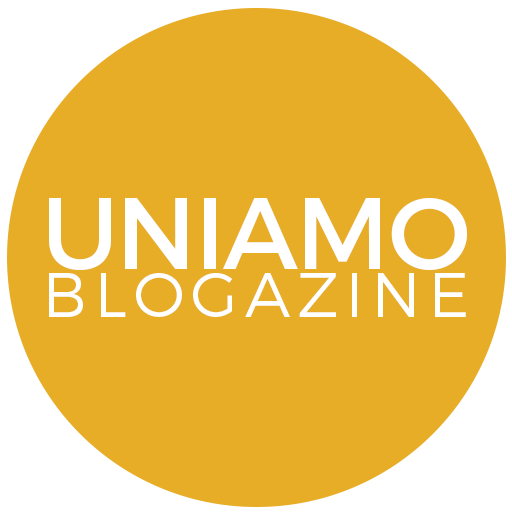Da qualche giorno Urbino si muove a un ritmo diverso. Il fermento del Career Day 2025 si diffonde con un’energia sottile nelle aule, nei corridoi dei palazzi che ospitano, dal 13 ottobre, i laboratori di orientamento e i seminari tematici. Addirittura nelle vie della città si sente la vibrazione di chi sta per fare un passo avanti verso ciò che immagina di diventare. Quando e dove? Il 23 ottobre al Collegio Raffaello, in Piazza della Repubblica 13, tra gli stand della Fiera delle Aziende.
E mentre i giovani di Uniurb si allenano a raccontarsi, ad affinare soft skill e conoscenze su IA e sostenibilità per reggere l’urto del lavoro che cambia, lo scorso 16 ottobre, si è svolto il seminario La Ricerca oltre l’Accademia che Alessandro Aldini, Delegato del Rettore ai Tirocini Formativi e al Placement, definisce «un primo evento di orientamento per i nostri giovani ricercatori che li aiuterà a cogliere nuove e sfidanti opportunità professionali. Questa edizione del Career Day – ha proseguito il Professor Aldini – vuole proporsi come forum che funge da ponte diretto tra le menti più brillanti della ricerca accademica e le aziende, le startup innovative e gli enti che cercano profili con un expertise specifico e profondo. Siamo infatti convinti che le competenze e le soft skills acquisite durante un percorso di dottorato e nella ricerca siano esattamente ciò che serve in un mercato del lavoro che ha fame di talento analitico, problem solving complesso e autonomia di gestione».
Di fatto, il seminario La Ricerca oltre l’Accademia ha acceso i riflettori sul destino professionale di ricercatrici e ricercatori, dottorande e dottorandi. Ne hanno parlato Giovanni Piersanti, Prorettore alla Ricerca; Marta Rapallini, Dirigente tecnologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Program Manager di Fondazione FAIR; Mariella Leporini, Innovation & Geothermal Energy Product Manager presso Saipem SpA; Mattia Aliano, Co-founder dello Spin-off Uniurb STE-Sanitizing Technologies and Equipments.
Nel suo complesso, il dibattito si inserisce in una fase di ampia riflessione e – si spera – di svolta del Sistema Italia. Secondo il Report 2025 di AlmaLaurea sulla Condizione occupazionale dei Dottori di ricerca, infatti, a un anno dal conseguimento del titolo il tasso di occupazione è pari al 91,2%. Un dato solo apparentemente rassicurante che, se osservato in profondità, lascia emergere un quadro generale più che frammentato. Tant’è che il 40,0% degli intervistati risulta occupato in attività puntellate da assegni di ricerca: forma contrattuale che rimane la più diffusa, in crescita rispetto all’anno precedente di 8,6 punti percentuali. Seguono i contratti a tempo indeterminato (24,8%) e quelli a tempo determinato (19,8%), mentre una quota più ridotta (7,0%) sceglie un’attività autonoma. Le borse post-doc, di studio o di ricerca, coprono un ulteriore 4,7% e altre percentuali marginali fanno riferimento a contratti formativi, collaborazioni coordinate e continuative o a impieghi privi di regolamentazione.
L’analisi, quindi, distingue nettamente due gruppi: chi era già inserito in contesti lavorativi consolidati prima del dottorato tende a conservare contratti stabili e attività in proprio; chi avvia la propria carriera dopo il conseguimento del titolo vi accede prevalentemente attraverso assegni di ricerca, borse o contratti a termine. L’occupazione complessiva cresce, ma la stabilità rimane un traguardo per pochi. È chiaro che in un tale scenario diventa sempre più urgente capire come trasferire i talenti della ricerca dall’accademia all’impresa e all’innovazione privata, in carriere strutturate.
«A fronte del riconoscimento del HR Excellence in Research Award ottenuto nel 2024 dalla Commissione Europea – ha spiegato il Prorettore alla Ricerca Giovanni Piersanti – l’Università di Urbino rafforza il proprio impegno nello sviluppo di politiche di supporto alla carriera delle ricercatrici e dei ricercatori (inclusi dottorandi), in linea con i principi della Carta Europea dei Ricercatori. Nel documento si evidenzia l’importanza di promuovere percorsi di carriera più ampi e aperti, capaci di valorizzare le competenze della comunità di ricerca anche al di fuori del mondo accademico.
È una visione che Uniurb condivide pienamente: nelle nostre strutture e gruppi di ricerca incoraggiamo la crescita di competenze analitiche, progettuali e relazionali, anche con attività formative per le competenze trasversali, un patrimonio che rappresenta un valore aggiunto anche oltre i confini universitari. Data la natura multidisciplinare dell’Ateneo, occuparsi di scienza a Urbino significa favorire la collaborazione tra saperi diversi, ed è proprio da questa rete di competenze che nasce una ricerca capace di produrre innovazione non solo tecnologica, ma anche culturale, sociale ed economica, che genera un impatto concreto sul territorio e nella società».
In questo orizzonte, anche la nostra Università diventa spazio di conoscenza in cui vive e respira l’intelligenza del Paese, ed è sempre qui che si colloca la sua vocazione più autentica, quella di formare menti in grado di osservare la realtà e dare impulso al pensiero che agisce.
«Il nostro personale di ricerca, fin dalle prime fasi della carriera – prosegue il Prorettore – sviluppa un mindset basato sulla risoluzione di problemi, ovvero un processo per analizzare e risolvere situazioni complesse o critiche utilizzando tecniche e metodi logici, creativi e strategici: caratteristiche sempre più richieste da imprese, istituzioni e centri di innovazione.
Non è raro che percorsi di ricerca nati a Urbino trovino naturale continuità nell’impresa, in centri di ricerca pubblici e privati o nella creazione di spin-off e startup, dove le competenze maturate in Ateneo diventano motore di trasformazione. Con l’iniziativa La Ricerca oltre l’Accademia Uniurb rinnova, dunque, la propria missione orientata a costruire connessioni tra università, industria e società, valorizzando il capitale umano e la ricerca multidisciplinare che ci distingue. Perché la conoscenza non è solo scoperta, ma anche futuro che prende forma».
Quando il sapere passa dalle aule ai luoghi di lavoro evidentemente si compie. Le competenze diventano esperienze, scienza e tessuto produttivo convergono e insieme diventano leva concreta di progresso che aggiunge valore in termini, anche, di occupazione, posizionamento e capacità competitiva per la storia che ci aspetta. Ne è convinta Marta Rapallini, Dirigente tecnologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Program Manager di Fondazione FAIR (Future Artificial Intelligence Research), progetto nato nell’ambito del PNRR come infrastruttura nazionale dedicata all’intelligenza artificiale.
«La Fondazione FAIR – spiega la Dirigente CNR – rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra ricerca pubblica e sistema produttivo. La Fondazione è nata come hub del progetto di Partneriato Esteso “Future Artificial Intelligence Research – FAIR”, unico progetto PNRR dedicato all’IA con il fine di rafforzare la competitività del Paese attraverso lo sviluppo di un ecosistema nazionale sull’intelligenza artificiale. Il partenariato ha messo a sistema 25 partner tra università, enti di ricerca e imprese, estendendo la propria rete, attraverso i bandi a cascata, a 136 membri complessivi presenti in 16 regioni italiane. L’ecosistema così costruito, che integra 53 università ed enti di ricerca e 83 imprese, ha generato una massa critica di competenze e innovazione capace di favorire un reale trasferimento tecnologico su scala nazionale».
Parliamo, quindi, di una piattaforma in grado di integrare persone e innovazione operativa. Un progetto che ha il duplice obiettivo di creare una base solida di abilità e know-how e promuovere un vero mercato del talento scientifico, capace di assorbire giovani ricercatori in ambienti di produzione ad alto contenuto tecnologico. La Dottoressa Rapallini lo ha chiarito con un esempio concreto.
«La Fondazione FAIR ha reclutato per le attività 485 giovani tra ricercatori, assegnisti e dottorandi. Si tratta di preziose risorse scientifiche e professionali che alla fine del PNRR potranno rimanere nelle università che le hanno reclutate, ma confidiamo che possano portare anche innovazione nelle imprese italiane. Per garantire loro migliori strumenti di orientamento al lavoro in azienda, abbiamo promosso un placement program espressamente rivolto ai neoreclutati: l’innovazione cammina attraverso le gambe delle persone e noi speriamo che i nostri reclutati di oggi, domani possano portare le loro competenze e la loro professionalità anche nel sistema produttivo del Paese.
Nel post PNRR, la Fondazione FAIR intende continuare a svolgere un ruolo strategico come piattaforma di dialogo tra ricerca di eccellenza e imprese, promuovendo la diffusione della conoscenza sull’IA, la formazione verso le imprese innovative che vogliano applicare l’intelligenza artificiale nelle loro aziende, con particolare attenzione all’etica e alla sostenibilità».
La conclusione che senz’altro riusciamo a trarre riguarda un processo che si è innescato a più livelli e che dobbiamo con forza consolidare. Se l’Italia si sta dotando di strumenti in grado di convertire il potenziale della ricerca in una risorsa produttiva stabile e qualificata, l’Università di Urbino continuerà a fare la propria parte in questa stessa direzione. Una sfida che ha accolto anche portando nell’aula del seminario, che abbiamo raccontato, testimonianze dirette su casi di collaborazione tra accademia e industria e di spinta verso l’imprenditorialità a partire da spin-off e startup.
A riprova di un disegno organico di interventi mirati a sostegno della transizione di dottorandi e ricercatori verso nuovi contesti professionali. In questa prospettiva in evoluzione, ciò che ci auguriamo è un largo cambio di passo e di pensiero collettivo per cui conoscenza e scienza si scrollino di dosso l’etichetta di costo o di input minore del sistema economico, per diventare ciò che realmente sono: asset fondamentali di scambio che reggono visione trasformativa, certamente rischio e soprattutto crescita.
*Nell’immagine di apertura i relatori: da sinistra il Prorettore alla Ricerca Giovanni Piersanti, Mariella Leporini e Mattia Aliano. La Dirigente CNR, Marta Rapallini era in collegamento da remoto.