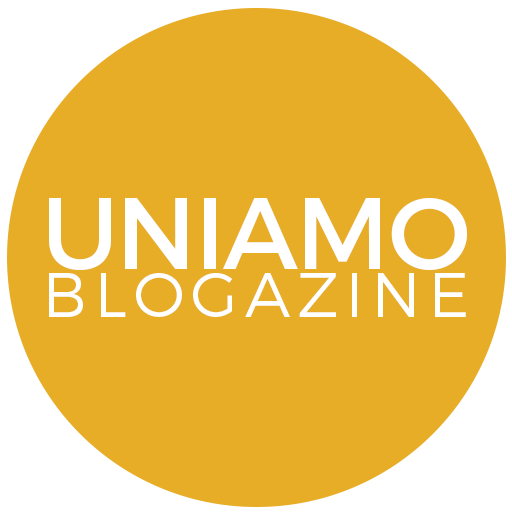In una Cina che domina il mercato globale e riscrive le regole del potere digitale, il riferimento a Mao Zedong continua ad attraversare con forza il linguaggio del Partito Comunista Cinese, le azioni di protesta della società civile, le aule delle Accademie. Mentre tutto scorre, Mao non passa: riletto, riusato, reinterpretato. Ma qual è il senso più profondo di questo cortocircuito, di questa contraddizione? E perché in un tempo in cui le democrazie occidentali mostrano incrinature evidenti, riflettere sul pensiero maoista può essere un atto di comprensione del presente? A questa e a molte altre domande proverà a rispondere, mercoledì 14 e giovedì 15 maggio 2025, il convegno internazionale Mao Zedong’s political thought and his legacy in the 21st Century, organizzato dal Dipartimento di Economia, Società, Politica. Per conoscere il programma cliccare qui.
Ne parliamo con Stefano Visentin, docente di Storia del pensiero politico, e con Asia Marcantoni, PhD in Global Studies. Economy, Society and Law.

Stefano Visentin
Perché un convegno su Mao, oggi?
Stefano Visentin ― L’idea è maturata gradualmente, da un confronto con la Dottoressa Asia Marcantoni – che stava concludendo un dottorato di ricerca in Global Studies – e con il suo supervisor, il Professor Guido Samarani, dell’Università di Venezia, uno dei maggiori esperti nazionali e internazionali di storia cinese contemporanea. Parlando della ricezione della democrazia in Cina, dal Novecento a oggi, è emersa la proposta di tornare a riflettere sul pensiero di Mao e, a quel punto, mi sono ricordato che nel 1986, proprio a Urbino, si tenne un’importante conferenza organizzata da Emilia Giancotti sul pensiero politico di Mao. Da qui l’idea di riprendere quel percorso di studio a quasi quarant’anni di distanza, creando una linea di continuità rispetto a uno dei momenti di alta divulgazione e di alto dibattito nel nostro Ateneo, e provando a rileggere il pensiero di Mao nel suo contesto storico per capire se, e in che misura, abbia ancora qualcosa da dire nel presente.
Asia Marcantoni ― Ad esempio, spesso sui media nazionali e internazionali si è sentito paragonare l’attuale leader cinese Xi Jinping a Mao Zedong. Il Time ha raffigurato Xi con l’immagine di Mao sullo sfondo, suggerendo un ritorno a quel modello. Ma è davvero questa la realtà dei fatti o parlare di Xi come del “nuovo Mao” è una semplificazione che non aiuta a capire la Cina di oggi? Per comprendere meglio il presente credo sia utile distinguere tra ciò che il Partito Comunista riprende da Mao in termini simbolici o propagandistici e ciò che, invece, è cambiato profondamente. Mao resta una figura centrale nella storia cinese: temuta da molti, venerata da altri. La sua eredità è ancora evidente, ma va analizzata con attenzione. Capire cosa resta davvero del maoismo e come il partito ne utilizza la memoria aiuta a interpretare meglio la Cina contemporanea.
Quali sono le linee di indagine dei diversi contributi?
Stefano Visentin ― Abbiamo invitato sei esperti di livello internazionale – provenienti da Stati Uniti, India, Hong Kong, Svezia e Italia – a tenere dei keynote speech sul pensiero di Mao e sulla sua eredità politica. A ciascuno di questi interventi abbiamo affiancato una coppia di discussant italiani: sinologi e studiosi di storia del pensiero politico, per garantire un confronto ampio e interdisciplinare. Il programma si articola in tre momenti principali. La prima giornata si aprirà con due interventi dedicati al confronto tra Mao Zedong e l’attuale segretario del Partito Comunista Cinese, Xi Jinping. Due letture diverse che serviranno da punto di avvio di una riflessione su come l’odierno sistema di governo politico cinese abbia in parte recepito e, in parte, neutralizzato l’eredità di Mao.
I lavori del 15 maggio si concentreranno sulla ricezione del pensiero maoista fuori dalla Cina. Si parlerà del rapporto tra Mao e il comunismo italiano, ma anche tra Mao e il movimento naxalita nel Bengala: uno dei pochi casi in cui l’ispirazione maoista ha ancora un ruolo attivo. L’ultima sessione proporrà: un intervento di carattere più filosofico e, in chiusura, un intervento che indaga la persistenza dell’immagine di Mao nella classe operaia cinese contemporanea.
Quali strumenti critici offre questa giornata di studio per un’interpretazione più o meno obiettiva della Cina del XXI secolo?
Stefano Visentin ― “Più o meno obiettiva”: credo sia giusto sottolinearlo. Le relazioni internazionali del mondo occidentale con la Cina sono, infatti, complesse e, spesso, le semplificazioni proposte dai media andrebbero filtrate e rielaborate in maniera critica. Il nostro intento è proprio quello di offrire strumenti per una lettura più approfondita e realistica dell’argomento. Agli occhi di molti, la Cina appare come un sistema “altro”, se non addirittura antagonista. Noi non aderiamo a questa visione, ma nemmeno a quella opposta che attribuisce alla Cina un ruolo guida rispetto al futuro dell’umanità.
Il nostro approccio è diverso: riteniamo che il compito degli studiosi sia quello di andare oltre gli schieramenti, di mettere in luce contraddizioni, tensioni, trasformazioni, senza nascondere aspetti problematici in grado, anzi, di stimolare riflessioni utili persino per le democrazie liberali, che oggi attraversano forti momenti di crisi. In questo senso, il riferimento a Mao ci permette di indagare l’ambivalenza della Cina contemporanea e di comprendere meglio le radici ideologiche, simboliche e politiche di un sistema ancora in evoluzione.

Asia Marcantoni
La Cina resta un grande mistero: è una potenza globale, capitalista, tecnologica, eppure il volto di Mao campeggia su piazza Tienanmen. Come si spiega questa contraddizione?
Asia Marcantoni ― La Cina oggi si presenta come una potenza capitalista e tecnologica certo, ma questa modernità convive – seppur con profonde contraddizioni – con il volto dell’uomo che in piazza Tienanmen ha annunciato la nascita della Repubblica Popolare Cinese. Del resto, il Partito Comunista Cinese che oggi governa è lo stesso nato nel 1921 a Shanghai e guidato da Mao. Ciò significa che anche dopo le grandi riforme economiche avviate nel 1978, il riferimento a questa figura fondamentale è sempre stato alimentato, seppure attraverso interpretazioni e adattamenti diversi.
Se, infatti, per il Partito resta un elemento di legittimità storica, rievocato e riletto da prospettive differenti, per una parte della società cinese e del mondo intellettuale rappresenta un’idea di giustizia sociale e di uguaglianza. In sintesi, per capire la Cina del XXI secolo è fondamentale osservare da quale angolazione politica e ideologica, società e cultura reinterpretano e si agganciano oggi, in modo selettivo e mirato, a una specifica eredità di Mao Zedong.
Conoscere meglio Mao nel 2025 significa capire i rapporti di forza e anche le tensioni che reggono il mondo contemporaneo?
Stefano Visentin ― Per comprendere alcune delle tensioni e delle contraddizioni legate alla globalizzazione potrebbe essere utile riflettere non tanto sulla presenza di Mao nel dibattito pubblico attuale, quanto sulla sua assenza. Negli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta del ‘900 Mao Zedong è stato una figura centrale non solo per la Cina, ma per gran parte del mondo in via di sviluppo. Il suo pensiero ha ispirato numerosi movimenti di liberazione in Africa, in Asia e in America Latina, offrendo un modello di prassi politica fondato non sulla classe operaia – pressoché inesistente in quei luoghi – ma sulla classe contadina come forza motrice del cambiamento sociale.
Anche in Occidente Mao fu un punto di riferimento per movimenti studenteschi e giovanili che si opponevano agli assetti consolidati del potere. Oggi, però, quella eredità rivoluzionaria è quasi del tutto scomparsa. L’unico Paese, oltre alla Cina, in cui il pensiero maoista si conserva è, probabilmente, l’India. Un contesto caratterizzato da forti contraddizioni, da una vastissima popolazione rurale e da recenti proteste di massa contro le politiche agricole del governo. Capire perché in India persista una traccia del maoismo, e cosa significhi questo rispetto al presente, sarà uno dei temi che approfondiremo durante il convegno.