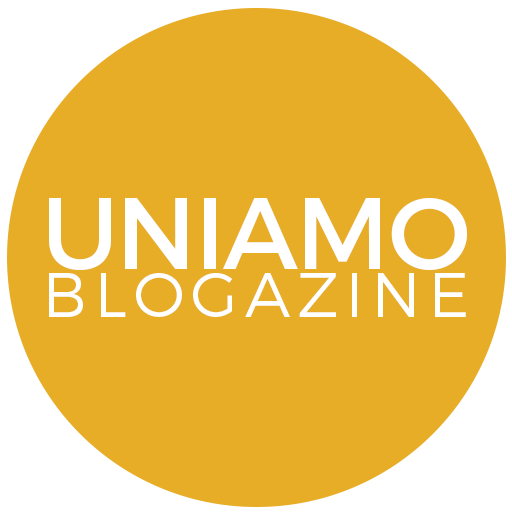Dante? È il padre della lingua italiana, certo, ma è anche un uomo che ha perso tutto e ha dovuto ricominciare da capo inanellando parole inarrivabili per ricostruire un mondo. E noi che attraversiamo il tempo difficile dell’incertezza non possiamo che sentirlo più che mai vicino e celebrarlo nel Dantedì del prossimo 25 marzo con un evento che si terrà alle 11.00 nell’Aula Magna del Rettorato, in via Saffi 2.
Ad aprire i lavori saranno i docenti Uniurb Antonio Corsaro e Ilaria Tufano. Seguirà la conferenza del Professor Vittorio Celotto, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che farà il punto su La profezia nella Commedia. Non mancherà la possibilità, per il pubblico, di approfondire la conoscenza del Poeta e della sua opera nel penultimo step dedicato a domande e curiosità. Concluderà la giornata di studio e divulgazione, la lettura del canto X dell’Inferno per voce del Professor Antonio Corsaro, Professore Ordinario di Letteratura Italiana.
I dettagli dell’iniziativa nell’intervista che segue alla Professoressa Ilaria Tufano, docente di Filologia e critica dantesca.
Professoressa Tufano, perché è importante continuare a raccontare Dante e la sua opera?
Dante è un poeta sempre attuale, come dimostra il fatto che è ancora capace di appassionare studentesse e studenti di ogni età. Le sue opere insegnano molte cose, una è la necessità dell’impegno civile e sociale di ognuno, perché la felicità del singolo dipende dalla società in cui vive e opera. È la società a permettere la concreta realizzazione delle potenzialità di ogni individuo, che ha il dovere e il diritto di essere civis. In un’epoca individualista come la nostra, è bene ricordarlo.
La profezia dantesca, tema del Dantedì 2025 di Uniurb, ha un ruolo centrale nella Commedia?
Nella fictio il viaggio ultraterreno del poeta-pellegrino ha inizio il 25 marzo, giorno del Capodanno fiorentino, dell’anno 1300, e ciò permette che siano numerose le profezie post eventum. Riguardano soprattutto gli eventi politici, la sorte ultraterrena di alcuni personaggi storici – penso a Bonifacio VIII, atteso tra i simoniaci – ma soprattutto il destino doloroso di Dante stesso, povero ed esiliato, in continua peregrinazione presso le altrui scale, ma dedito senza compromessi alla giustizia. Talvolta è il Poeta a porsi come profeta davanti alla città corrotta, sulla scorta del veterotestamentario Geremia di fronte a Gerusalemme. Il Professor Celotto, durante la sua conferenza spiegherà la ricezione che di alcune profezie ebbero gli antichi commentatori.
L’evento prevede anche la lettura di Inferno X per voce del Professor Antonio Corsaro. Ci spiega le ragioni della scelta del canto?
Fra i canti profetici è certamente il più noto e quello che si impone anche sotto il profilo emotivo. Sebbene fu uno dei fautori della strage di Montaperti, il cui effetto fu tale che dopo di essa a Firenze il patriottismo si identificò con il guelfismo, Farinata è rappresentato come magnanimo anche all’Inferno. La sua immobilità statuaria, la sua eroica solitudine al concilio di Empoli, in cui difende a viso aperto Firenze dalla distruzione auspicata dagli altri ghibellini, la sua altissima figura che si erge dalla cintola in su dall’arca è impressa nella memoria dei lettori di ogni epoca. Aggiungo che il cronista Giovanni Villani, morto nel 1348, nei suoi capitoli dedicati a Farinata, ci consegna ben altro ritratto, quasi antitetico: una volpe e non un leone.
Per quali caratteristiche il canto X può sollecitare l’attenzione di un pubblico moderno?
C’è la grande figura politica, il ghibellino Farinata, le cui passioni verso le cause civili non sono sopite neanche dopo la dannazione, ma pure la figura del padre, il guelfo Cavalcante in angoscia per il figlio Guido, in una sapiente alternanza tra la dimensione pubblica e la dimensione privata all’insegna del dolore, nello spazio buio e cimiteriale della città di Dite. Inoltre, il canto è un esempio straordinario di dialogo serrato, con movenze teatrali, tra fiorentini, in una lingua straordinariamente vicina alla nostra.
Qual è il valore aggiunto della lettura ad alta voce della Commedia?
La lettura ad alta voce è fondamentale – è stata sempre fatta fin dalle prime generazioni dopo Dante – il Poema si leggeva in chiesa così come in contesti laici. La narrazione della Commedia ha una sua dimensione pubblica, il testo si fa capire anche in questo modo perché si rivolge potentemente alla collettività. Da Boccaccio a Benigni, la Commedia è un testo ambiziosissimo che chiede di essere letto in pubblico.
L’evento sarà aperto al grande pubblico o solo alla comunità accademica?
Il carattere divulgativo dell’evento consente che esso sia aperto a tutti e fruibile anche in streaming attraverso questo link. In ogni modo, il Professor Corsaro ed io abbiamo pensato che l’orizzonte d’attesa più plausibile sarà rappresentato dalle studentesse e dagli studenti di Scienze Umanistiche e del corso di laurea magistrale di Lettere Classiche e Moderne dell’Università di Urbino. Ci aspettiamo che vengano numerosi.