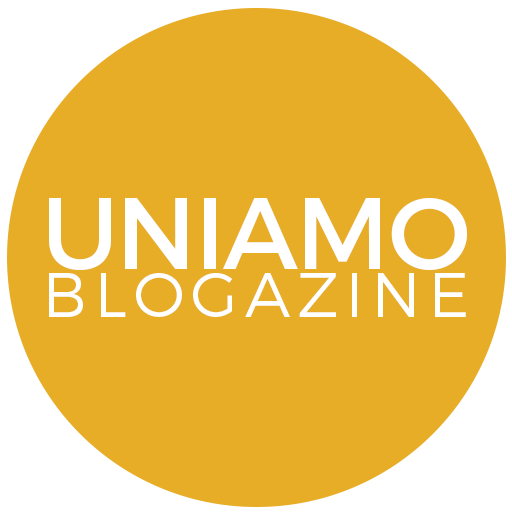L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato di recente le nuove linee guida sulla Valutazione medico-legale delle menomazioni all’integrità psico-fisica tra 10 e 100 punti di invalidità permanente. Il documento è stato elaborato dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni – SIMLA secondo un rigoroso impianto metodologico che ha coinvolto una comunità ampia e interdisciplinare di esperti. Del comitato tecnico-scientifico che ha prodotto la direttiva nazionale ha fatto parte anche il Professor Marco Rocchi, docente di Statistica medica e Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari di Uniurb.

Il Professor Marco Rocchi
Professor Rocchi, quali criticità hanno reso necessario il rinnovamento del sistema di valutazione del danno alla persona?
L’esigenza è nata perché non esisteva un sistema di riferimento formalizzato com’è adesso. Mancava un modello condiviso ufficiale che consentisse di valutare i danni alla salute della persona, e questo lasciava un eccessivo margine di discrezionalità. Una stessa lesione – come la perdita della funzionalità di un dito ad esempio – poteva essere considerata gravissima da qualcuno e trascurabile da qualcun altro e questo creava disparità e ingiustizie. Le nuove linee guida definiscono, invece, criteri comuni e riferimenti chiari che rendono le valutazioni più omogenee, eque e affidabili.
Le nuove linee guida sono state decise da un comitato tecnico-scientifico di esperti di cui lei ha fatto parte, è esatto?
Sì. Il comitato tecnico-scientifico, nella sua composizione più ristretta, era formato da due medici legali – il Dottor Lucio di Mauro e la Dottoressa Gloria Castellani – da un metodologo della consensus conference: il Dottor Giovanni Pomponio, Dirigente Medico AOU Ospedali Riuniti Ancona, e da me in qualità di statistico medico. Quindi, ai medici legali è stato affidato il compito di seguire la parte disciplinare, al Dottor Pomponio e a me di curare la parte metodologica. Oltre a questo nucleo operativo, alla stesura del documento ha contribuito un panel molto ampio di esperti.
La soddisfazione condivisa è quella di aver portato a termine un lavoro che oggi rappresenta un riferimento nazionale perché è stato voluto e accolto dall’Istituto Superiore di Sanità, che lo ha pubblicato sul proprio sito ufficiale. Parliamo quindi di un risultato che dà valore alla ricerca e anche alla “terza missione” della nostra Università. Il contributo scientifico dei membri del comitato oggi trova, infatti, applicazione nella medicina legale e delle assicurazioni e ricade, di conseguenza, sulla vita della persona che subisce un danno e che può contare su una valutazione chiara e obiettiva della propria invalidità.
Perché è importante il contributo della statistica medica nella valutazione del danno alla persona?
La statistica medica è una disciplina che non ha a che fare solo con i numeri, ma riguarda la metodologia e quindi il modo in cui si costruiscono le analisi, si interpretano i dati e si prendono decisioni fondate sull’evidenza. La società scientifica di riferimento, ad esempio, non si chiama Società Italiana di Statistica Medica, ma si chiama Società Italiana di Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica (SISMEC). Nome che ci ricorda quanto il metodo e il contesto clinico siano componenti importanti di questo lavoro. Inoltre, il settore scientifico-disciplinare, nella declaratoria, contiene chiaramente e ripetutamente la parola “metodologia”.
Quindi noi ci occupiamo di metodologia, che spesso vuol dire anche metodologia statistica in senso stretto. Un aspetto che nel caso in questione è stato fondamentale perché mentre un team di esperti proponeva dei valori numerici, dei range, per indicare il grado di invalidità associato a varie menomazioni, noi abbiamo applicato una procedura statistica che ci ha permesso di raccogliere quei dati, di confrontarli e di trovare un punto di equilibrio tra valori troppo alti e valori troppo bassi, e di identificare un nucleo centrale maggiormente condiviso. Per cui, dovendo quantificare un danno e definire percentuali precise il contributo della statistica, intesa nel suo significato più completo, si è rivelato importante.
A una lesione corrisponde un valore. Proviamo a portare un esempio concreto?
Immaginiamo una persona che perde un braccio a seguito di un incidente. Qual è la percentuale di invalidità? Questa potrebbe essere la domanda iniziale alla quale i medici legali farebbero seguire una serie di altri interrogativi come: si tratta del braccio dominante? Perché per una persona destrorsa perdere il braccio destro sarebbe un’invalidità gravissima, perdere il braccio sinistro sarebbe un’invalidità molto grave con un impatto però diverso sulla vita quotidiana.
Ma non finisce qui, in quanto anche il punto in cui avviene l’amputazione fa la differenza per la possibilità di innestare o meno una protesi. Come si vede, dettagli diversi modificano il peso della valutazione. Per questo, il primo passo del lavoro è stato suddividere le domande sulla base degli esiti possibili. Definita la griglia di opzioni, gli esperti hanno assegnato un peso numerico a ciascuna condizione con l’obiettivo di garantire una valutazione realistica del danno.
A proposito di valutazioni: cosa ha rappresentato per lei questa esperienza interdisciplinare, quanto ha aggiunto sul piano professionale e umano?
Ha aggiunto molto perché ho interagito con persone fantastiche che hanno reso il lavoro molto interessante e piacevole. Tutti abbiamo trattenuto qualcosa dal fare dell’altro. Io certamente ho imparato molto. Per cui, con la pubblicazione delle linee guida si è conclusa un’esperienza che – ripeto – riguarda la ricerca, ma soprattutto la “terza missione” della nostra Università per la fondamentale ricaduta sociale che comporta.