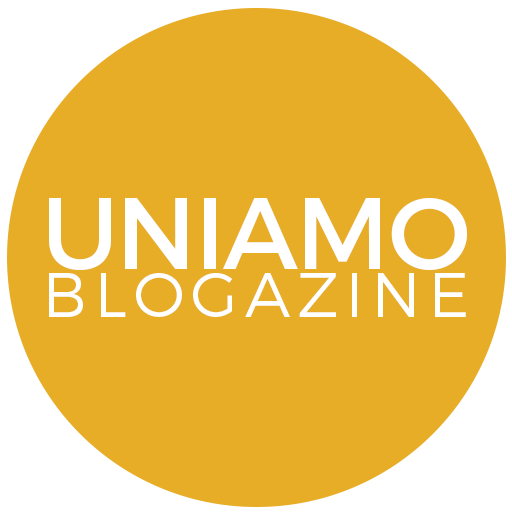Si può prevedere un terremoto? Ancora no, eppure la scienza continua a intercettare importanti segnali idrogeochimici e a rafforzare reti di sorveglianza sismica. Un contributo a questa linea di ricerca arriva dallo studio Groundwater hydrogeochemical changes predating and following the November 9, 2022 Mw 5.5 Adriatic offshore earthquake (central Italy), pubblicato di recente sulla rivista scientifica Journal of Hydrology. L’indagine, coordinata dalla sezione di Geoscienze del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate di Uniurb, è stata condotta in collaborazione con l’Università di Firenze, l’Università Politecnica delle Marche, l’Università di Camerino, il CNR-IGG e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ne parliamo con due autori dell’articolo: Lorenzo Chemeri, Assegnista di ricerca, e Marco Taussi, Ricercatore Area Geochimica e Vulcanologia, del nostro Ateneo.

Lorenzo Chemeri
Da quali esigenze scientifiche ha origine lo studio?
Lorenzo Chemeri ― Negli ultimi decenni l’osservazione di variazioni geochimiche che precedono eventi sismici ha suscitato un certo interesse scientifico. In particolare, si studiano i cambiamenti della composizione delle acque sotterranee, dei tassi di emissione dei gas e altri specifici parametri chimico-fisici. Questo tipo di studi è stato sviluppato soprattutto in aree ad alta sismicità come il Giappone, l’Islanda e l’Italia stessa. Nell’Italia Centrale, ad esempio, la provincia di Pesaro e Urbino rappresenta un’area abbastanza attiva dal punto di vista sismico, per cui proprio in questo contesto si è sviluppato lo studio, avviato nell’ambito del mio dottorato di ricerca in Research Methods in Science and Technology, con l’obiettivo di esplorare possibili traccianti geochimici correlabili ai processi geologici che anticipano un sisma. Durante l’indagine, l’opportunità concreta di mettere alla prova la procedura di monitoraggio e approfondire la possibile correlazione tra variazioni idrogeochimiche e dinamiche sismiche si è verificata quando, il 9 novembre del 2022, un terremoto di magnitudo 5.5 ha scosso le coste dell’Adriatico.
Come si è svolto il monitoraggio idrogeochimico?
Marco Taussi ― Il monitoraggio è iniziato il giorno dopo il terremoto e, per oltre un anno, si è basato sul campionamento sistematico di acque sotterranee attraverso un piezometro, cioè un foro profondo – 30 metri nel nostro caso – che intercetta l’acqua della falda e consente di analizzarne la composizione. Dopo indagini preliminari svolte presso la sezione di Geoscienze del DiSPeA del nostro Ateneo, analisi di laboratorio approfondite sono state condotte presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze e hanno riguardato prevalentemente: ioni principali, quindi cationi e anioni; elementi in traccia come boro, litio e manganese; isotopi dell’ossigeno e dell’idrogeno, ma anche parametri fisico-chimici come temperatura e conducibilità elettrica.
Ci tengo a precisare che questa ricerca è il risultato di un lavoro sinergico tra il gruppo di geochimica del nostro Ateneo – che oltre a me e a Lorenzo comprende il Professor Renzulli – e altre Università e centri di ricerca: Firenze (Prof. Vaselli), Politecnica delle Marche (Dott. Fronzi e Prof. Tazioli), Camerino (Prof. Mazzoli), e CNR-IGG (Dott. Cabassi). In particolare, grazie alla collaborazione con il Dottor Fronzi – oggi docente a contratto anche di Uniurb – e con il Professor Tazioli siamo riusciti ad accedere a dati già disponibili da maggio 2022, sei mesi prima del terremoto, in tre siti della zona del Conero inizialmente monitorati per altri scopi. Per cui confrontando le informazioni pre e post sisma abbiamo potuto osservare variazioni idrogeochimiche intervenute a causa del terremoto, di un’entità rarissimamente rilevata prima.
Quali dati sono emersi e perché sono importanti?
Lorenzo Chemeri ― A partire dalla fine di giugno 2022 – quattro mesi prima del terremoto – le analisi dell’acqua prelevata dal piezometro hanno mostrato una netta variazione della composizione chimica, passata da bicarbonato-calcica a clorurato-sodica, con un aumento della salinità da meno di 1000 mg/L a quasi 4000 mg/L. Questa anomalia si è mantenuta fino a pochi giorni dopo il sisma del 9 novembre 2022, per poi ritornare gradualmente verso la composizione originaria una settimana dopo l’evento. Inoltre, a ridosso dell’evento sismico si è notato un forte aumento dei metalli pesanti, anche fino a 50 volte rispetto alle loro concentrazioni pre-terremoto.
La variazione nella composizione chimica delle acque sotterranee è stata una tra le maggiori osservate in letteratura, quindi, possiamo dire che i risultati hanno decisamente superato le nostre aspettative. Inoltre, la combinazione dei dati chimici, idrogeologici e strutturali raccolti suggerisce che, nella fase pre-sismica, l’aumento dello stress tettonico abbia favorito la risalita di acque profonde più saline, e anche che, durante il sisma, l’energia rilasciata dall’evento abbia mobilizzato materiali contenuti nelle fratture della roccia, determinando l’elevata concentrazione in metalli pesanti. In generale, lo studio approfondisce e amplia l’interpretazione delle dinamiche idrogeochimiche legate ai terremoti, e rafforza e dimostra il valore del monitoraggio costante.

Marco Taussi
La ricerca potrebbe avere ricadute in tema di gestione della sicurezza territoriale?
Marco Taussi ― La ricerca rappresenta un importante passo avanti nello studio dei segnali idrogeochimici anomali legati agli eventi sismici. Questo tipo di monitoraggio può offrire informazioni preziose, ma per essere davvero efficace deve potersi adattare alle caratteristiche specifiche di ciascun sito. Ogni luogo ha un assetto idrogeologico diverso e rocce differenti nel sottosuolo, pertanto ciò che è stato osservato nel territorio del Monte Conero, ad esempio, potrebbe non verificarsi altrove. Per questo motivo è fondamentale non generalizzare i risultati, ma conoscere bene ogni zona di osservazione considerata sismo-sensibile, cioè particolarmente reattiva dal punto di vista geochimico ai terremoti, e mantenere attivo il monitoraggio in queste aree. Detto ciò, anche se siamo ancora lontani dal poter emettere allerte basate su variazioni geochimiche, stiamo raccogliendo dati fondamentali che ci auguriamo possano, un giorno, contribuire alla prevenzione del rischio sismico.
Si tratta quindi di un’indagine aperta? Lo studio continua?
Marco Taussi e Lorenzo Chemeri ― La ricerca prosegue, sì. Il lavoro di tesi di dottorato ha prodotto risultati significativi e in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con il quale Uniurb ha recentemente siglato un accordo quadro, è prevista l’installazione di sonde multiparametriche in grado di monitorare costantemente temperatura e conducibilità elettrica delle acque sotterranee e livello della falda idrica. Una prima sonda è già attiva nella zona di Cagli, e stiamo valutando l’installazione di altri due dispositivi tra la provincia di Pesaro e Urbino e quella di Ancona, nell’ambito di un piano nazionale di sorveglianza sismica attraverso il monitoraggio idrogeochimico. L’obiettivo è quello di accrescere la conoscenza dei segnali che precedono i terremoti in siti sensibili, e creare una rete di monitoraggio coordinata ed estesa, in tutto il territorio italiano.